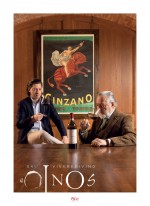Davanti a voi la grande Leptis Magna, a sinistra il Peloponneso, a destra Cartagine, sulle colline alle vostre spalle i vigneti di Feudo Maccari, piantati a sorvegliare Capo Passero e l’Isola delle Correnti, dove, per secoli, si sono combattute le flotte greche, cartaginesi e romane. Siamo nel cuore del Mediterraneo, tra Oriente e Occidente, Nord e Sud, caldo scirocco e sferzante tramontana, fichi d’India e olivi, dove il mare colora di azzurro, da tre millenni, le grandi opportunità di commercio e di conoscenza tra gli astuti popoli di Ulisse.
 È a Noto, sugli scogli e sulle spiagge del lembo di terra italiana più meridionale, che Antonio Moretti, imprenditore del tessile di successo e titolare della Tenuta Sette Ponti sulle colline di Arezzo, sfondo bucolico del misterioso sorriso della Gioconda di Leonardo, dove nasce il supertuscan Oreno, ha vinto la sua sfida personale. Affascinato e stordito da un viaggio nel barocco siciliano della Val di Noto, la più imponente e spiazzante opera di ricostruzione mai realizzata nell’isola dopo il terremoto del 1693, Moretti, alla fine degli anni Novanta, decise di produrre proprio qui, tra la Siracusa di Archimede e Ragusa, nella valle di Noto, il più grande vino della sua vita. Per avere buona frutta il terreno deve essere fertile, come solo un suolo vulcanico può diventare, la terra nera e bianca è sempre stata generosa coi suoi contadini, capaci di prendersi cura di lei. Ecco perché, sin dai primi insediamenti umani, la Sicilia Orientale è il posto ideale per fare agricoltura di qualità. L’Etna non è un vulcano traditore e vendicativo come il Vesuvio, spennacchia in continuazione, qualche volta minaccia, se l’uomo non è capace di rispettarlo, ma si riesce a conviverci senza grandi rischi. Lo hanno capito subito gli Arabi, quando tappezzarono la Sicilia di agrumeti, creando un complesso e ingegnoso sistema di canali d’irrigazione, capace di portare l’acqua ovunque. Per secoli, millenni, solo tanta fatica e sudore sotto i pennacchi del vulcano amico. In compenso, le sterminate distese di arance e limoni, oggi il pomodorino di Pachino, la verdura e gli ortaggi, le olive hanno un sapore unico, tipico, irripetibile; soprattutto l’uva, grazie alla combinazione magica tra il terreno vulcanico, il sole e la costante ventilazione, che conserva il grappolo sano perché mai stressato dal caldo eccessivo. Non è dunque un caso se è da questo terroir, ricco di storia agricola, che il vitigno autoctono più rappresentativo della Sicilia prende il nome, quello dell’importante centro di Avola, a due passi da Noto. Il grande vivaista francese Gilbert Bouvet, una vita dedicata alle barbatelle e ai portainnesti, non ha dubbi quando consiglia a Moretti di puntare su quest’uva perché, a suo giudizio, non può esserci zona migliore in Sicilia per coltivarla. Tonno, agrumi e uva: per secoli la gente di Avola ha vissuto portando al mercato i regali generosi del mare e della terra. Qui nasce dunque uno dei più grandi vitigni del Mezzogiorno, il Nero d’Avola, le cui origini risalgono sicuramente ai primi insediamenti greci, quando i coloni portarono anche la sapienza del sistema di coltivazione ad alberello, talmente efficace da esser usato ancor’oggi comunemente in molte zone del Sud. È proprio il Nero d’Avola il protagonista delle esportazioni di vino sfuso dalla Sicilia per tutto l’Ottocento, grazie all’alto grado alcolico raggiunto senza difficoltà, che gli consente di essere ben conservato per sostenere il viaggio anche con rudimentali sistemi di trasporto. Come l’Aglianico nel Vulture o il Negroamaro nel Salento, i rossi meridionali sono stati usati, sino a qualche vendemmia fa, per sostenere le produzioni del Nord d’Italia e della stessa Francia, soprattutto quando le pallide annate non erano favorevoli. Poi la grande svolta, iniziata nella metà degli anni Ottanta, sino al boom di questi ultimi anni: il Nero d’Avola, vinificato in purezza, si rivela un rosso elegante, ben strutturato, complesso, fine, rotondo, perfettamente in grado di affrontare lunghi invecchiamenti.
È a Noto, sugli scogli e sulle spiagge del lembo di terra italiana più meridionale, che Antonio Moretti, imprenditore del tessile di successo e titolare della Tenuta Sette Ponti sulle colline di Arezzo, sfondo bucolico del misterioso sorriso della Gioconda di Leonardo, dove nasce il supertuscan Oreno, ha vinto la sua sfida personale. Affascinato e stordito da un viaggio nel barocco siciliano della Val di Noto, la più imponente e spiazzante opera di ricostruzione mai realizzata nell’isola dopo il terremoto del 1693, Moretti, alla fine degli anni Novanta, decise di produrre proprio qui, tra la Siracusa di Archimede e Ragusa, nella valle di Noto, il più grande vino della sua vita. Per avere buona frutta il terreno deve essere fertile, come solo un suolo vulcanico può diventare, la terra nera e bianca è sempre stata generosa coi suoi contadini, capaci di prendersi cura di lei. Ecco perché, sin dai primi insediamenti umani, la Sicilia Orientale è il posto ideale per fare agricoltura di qualità. L’Etna non è un vulcano traditore e vendicativo come il Vesuvio, spennacchia in continuazione, qualche volta minaccia, se l’uomo non è capace di rispettarlo, ma si riesce a conviverci senza grandi rischi. Lo hanno capito subito gli Arabi, quando tappezzarono la Sicilia di agrumeti, creando un complesso e ingegnoso sistema di canali d’irrigazione, capace di portare l’acqua ovunque. Per secoli, millenni, solo tanta fatica e sudore sotto i pennacchi del vulcano amico. In compenso, le sterminate distese di arance e limoni, oggi il pomodorino di Pachino, la verdura e gli ortaggi, le olive hanno un sapore unico, tipico, irripetibile; soprattutto l’uva, grazie alla combinazione magica tra il terreno vulcanico, il sole e la costante ventilazione, che conserva il grappolo sano perché mai stressato dal caldo eccessivo. Non è dunque un caso se è da questo terroir, ricco di storia agricola, che il vitigno autoctono più rappresentativo della Sicilia prende il nome, quello dell’importante centro di Avola, a due passi da Noto. Il grande vivaista francese Gilbert Bouvet, una vita dedicata alle barbatelle e ai portainnesti, non ha dubbi quando consiglia a Moretti di puntare su quest’uva perché, a suo giudizio, non può esserci zona migliore in Sicilia per coltivarla. Tonno, agrumi e uva: per secoli la gente di Avola ha vissuto portando al mercato i regali generosi del mare e della terra. Qui nasce dunque uno dei più grandi vitigni del Mezzogiorno, il Nero d’Avola, le cui origini risalgono sicuramente ai primi insediamenti greci, quando i coloni portarono anche la sapienza del sistema di coltivazione ad alberello, talmente efficace da esser usato ancor’oggi comunemente in molte zone del Sud. È proprio il Nero d’Avola il protagonista delle esportazioni di vino sfuso dalla Sicilia per tutto l’Ottocento, grazie all’alto grado alcolico raggiunto senza difficoltà, che gli consente di essere ben conservato per sostenere il viaggio anche con rudimentali sistemi di trasporto. Come l’Aglianico nel Vulture o il Negroamaro nel Salento, i rossi meridionali sono stati usati, sino a qualche vendemmia fa, per sostenere le produzioni del Nord d’Italia e della stessa Francia, soprattutto quando le pallide annate non erano favorevoli. Poi la grande svolta, iniziata nella metà degli anni Ottanta, sino al boom di questi ultimi anni: il Nero d’Avola, vinificato in purezza, si rivela un rosso elegante, ben strutturato, complesso, fine, rotondo, perfettamente in grado di affrontare lunghi invecchiamenti.
È sicuramente la scoperta enologica più interessante e ha contribuito, più d’ogni altra uva, al rilancio dei grandi rossi del Sud d’Italia.
Moretti non ha mai avuto dubbi sulla scelta, immediatamente ha puntato su questo vitigno autoctono, lavorando l’uva col sistema tradizionale ad alberello: “Ce lo hanno insegnato i Greci – ci dice Antonio Moretti – e ha sempre funzionato!”. Tra le siepi di fichi d’India e l’ombra fresca degli alberi di carrubo, tra ulivi e mandorleti in fiore, le palme nane impotenti e i fertili limoneti, spuntano gli splendidi e suggestivi impianti ad alberello di Nero d’Avola: Feudo Maccari si estende su circa 1000 tumuli (antica unità di misura dell’isola di Sicilia, per la quale 1 tumulo è eguale a 1744 metri quadrati), di cui circa 450 a vigna, divisi in tre corpi sparsi sulle colline accarezzate notte e giorno dalla brezza marina. L’avventura di Moretti in questa natura esuberante, esagerata e barocca, comincia nel 2000 coi primi acquisti. Tumulo dopo tumulo, riesce a costruire una delle più grandi realtà dell’isola, mettendo insieme la proprietà, spezzettata dal tempo, di oltre cinquanta proprietari diversi. All’ombra della Cattedrale di Noto, Antonio e la figlia Monica cominciano a impostare l’affascinante e rigoroso lavoro di recupero filologico del passato. Il cuore è Maccari, corrispondente a oltre il 70% del Feudo, dove i vigneti, che hanno già fatto una trentina di vendemmie, sono sotto il sole tutto il giorno. Qui la foresteria, alcune abitazioni, la sala degustazione e la cantina, riprese e restaurate. E la nuova, grande cantina con al piano seminterrato una barriccaia di 600 mq, al piano terra una tinaia di 500 mq, e al primo piano gli uffici, la sala degustazione e una zona adibita alla lavorazione delle uve moscato per il vino dolce Sultana. Non lontano l’altro corpo aziendale, una contrada particolarmente vocata per la viticoltura, perché la conformazione del terreno trattiene l’umidità, un particolare decisivo in un territorio siccitoso dove Greci, Romani e Arabi hanno sempre dovuto fare i conti con la mancanza d’acqua. Infine il punto più alto dell’azienda, una terrazza sullo Jonio e sull’oasi naturale di Vendìcari, la zona di contrada Gerbi e di contrada Timponazzo, dove la diversa tipologia tra i terreni, neri e sabbiosi o bianchi calcarei, le differenze d’altezza e d’esposizione, tutto sembra creato volutamente per favorire la nascita di vini complessi e consentire di riequilibrare il diverso andamento vegetativo delle piante. E per concludere questo nostro viaggio nel mondo siciliano di Antonio Moretti, non resta che parlare dei suoi vini, dai nomi sempre intriganti. Iniziamo col “Mahâris”, nome arabo legato alle torri d’avvistamento, perchè dalla torre si scrutava il mare per avvistare i nemici partiti dall’Oriente per depredare e rapire le donne più belle, nella torre si fumava, si beveva e si parlava, dalla torre si sorvegliava il traffico di spezie, frutta e uomini. Così gli arabi chiamavano la torre d’avvistamento, costruita vicino al porto, e “Mahâris” è il nome voluto da Antonio per il suo vino più imponente, l’incontro fra la grande tradizione siciliana del Nero d’Avola con la straordinaria espressione dei vitigni internazionali. Mahâris, incontro fra le genti, blend di uve, sentinella dei mari e del piacere.
“Saia” deriva invece dai canali d’irrigazione costruiti dagli Arabi per raccogliere l’acqua pluviale. Nella bottiglia c’è tutta la storia austera e tenace della Sicilia, un Nero d’Avola di gran carisma: il colore è impenetrabile, il frutto esplode subito al naso, per poi lasciar posto a sensazioni olfattive intense, persistenti e complesse di spezie, cacao, liquirizia. Un equilibrio confermato sin dal primo sorso e ottenuto con l’uso sapiente del legno, scelto dopo molte prove, per elevare questo rosso sontuoso, in cui si concentra la forza del terroir e la sapienza dell’enologo, capace d’interpretare al meglio un vitigno in costante ascesa, ma che, in realtà, pochi conoscono ancora bene. Ecco poi il “Nero d’Avola”: “Pan d’un giorno, vin d’un anno”, da sempre i contadini meridionali amano bere il frutto dell’ultima vendemmia prima di cominciare la nuova. Una tradizione a cui Moretti è andato subito incontro con entusiasmo: il bicchiere allegro e scanzonato, pronto in ogni occasione, ricco di profumi, facile da abbinare alla superba tradizione gastronomica siciliana, fatta di povertà e ricchezza, riflette in pieno il suo carattere aperto di uomo del Sud. Feudo Maccari ha voluto rispettare fino in fondo l’uva con un’attenta vinificazione in acciaio, al resto ci hanno pensato il suolo nero, il sole e i venti africani, che raccontano l’anima del Nero d’Avola in bottiglia. E finalmente un bianco siciliano, il “Grillo”, perché la sfida di Feudo Maccari continua, la scalata alla qualità assoluta del vino siciliano fa tappa anche tra i bianchi.
Non uno qualsiasi, ovviamente, ma un grande interprete della vitienologia classica dell’isola, da sempre compagno fedele e versatile di tanti stili e altrettante denominazioni. Un Grillo in purezza, dunque, che ammalia per la capacità di parlare una lingua antica, per certi versi arcaica, in maniera del tutto contemporanea. Infine non può mancare un grande vino dolce, in una cantina che intenda preservare le migliori tradizioni enologiche siciliane. E soprattutto non può mancare un vino che esalti il carattere di un’uva magica, in perfetta simbiosi con l’isola come il moscato. Il Sultana è un vino che ammalia, dunque, e che ricorda il barocco di Noto per l’impostazione ricca, di grande impatto, ma allo stesso tempo equilibrata e raffinata.